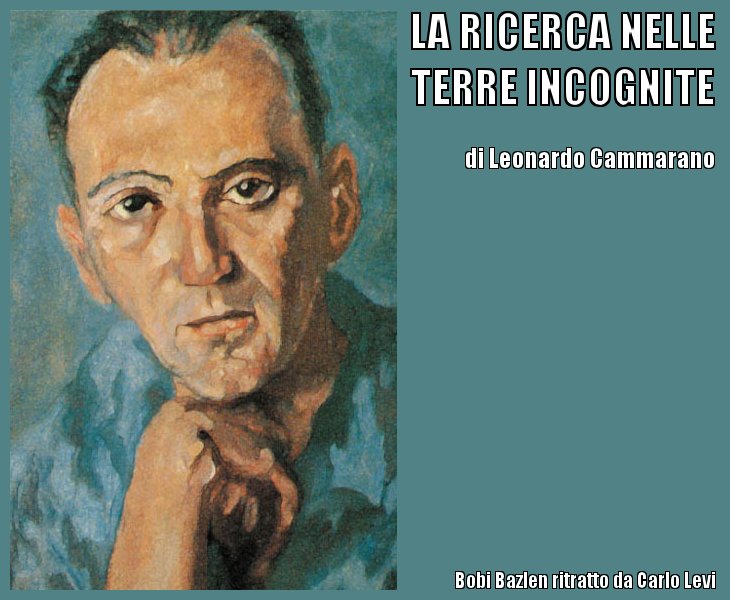
Distratti dal nostro “nulla quotidiano” (Proust), pensiamo poco ad un fatto molto triste: l’odierna situazione politica, tanto prosaica e brutale, ci esclude dalla poesia della nostra terra, dall’Italia. Ormai ciechi e sordi, ci dimentichiamo che l’Italia non è affatto, e non solo, un campo di battaglia per volgari contese tra personaggi di terz’ordine. Ho dimenticato, io napoletano, quella terra benedetta, contesta di sogni e di ricordi gentili, che fu la Campania fino agli anni 1960, prima che esplodesse l’irreparabile “tsunami” della politica di seconda scelta e della Camorra, le due ignobili produttrici di ceffi non si sa se contrapposti tra loro, o ignobilmente collusi.
Nei primi anni ’60 dello scorso secolo circolavo molto spesso nei dintorni incantati di una città che ha perduto l’anima -, perduta perché sbiadita, svuotata del senso e delle risonanze “spettrali” (Musil) dei suoi ricordi; e poi involgarita quasi al punto di poter dire che “non c’è più”.
Ricordo con una “fitta al cuore” (si possono ancora usare espressioni del genere?) le mie peregrinazioni nei Campi Flegrei, con amici e familiari anch’essi quasi tutti scomparsi. Li rivedo come illuminati da un perenne immaginario tramonto (ahimé, chi ricorda più Santa Maria la Bruna, il villaggio dei pescatori vesuviani e della poesia dei fichi d’India? Là i Campi Flegrei, esposti ad Occidente, erano famosi per la bellezza delle lunghe sere, appunto “brune” e dorate); mio padre con la sua ‘600, mia madre tra i pini di Torre del Greco coi suoi pennelli, il musicologo Edoardo Guglielmi, sempre un po’ troppo bisbetico; Bobo Bazlen nelle sue rarissime gite napoletane; le sorelle Zambrano e Ramόn Gaya; e prima ancora, Carlo Massa, “il fuochista dei sogni”, che dava fuoco ai suoi fatati vaneggiamenti intorno all’eterno tema dell’arte.
All’epoca, già più che trentenne, ero ancor più timido di quanto sia ora, a 50 anni di distanza. Lasciavo correre occasioni di lavoro per me importanti, a causa d’una irrefrenabile tendenza a mettermi da parte. Ed ecco che un giorno di luglio piomba a casa mia Roberto Bazlen, credo per discutere con mia cognata questioni relative alla Editrice Adelphi, da poco messa sù con Roberto Calasso e, credo di ricordare, Elémire Zolla. Mia cognata, ad un certo punto del pomeriggio, deve recarsi ad un incontro letterario-mondano, e con mio scombussolamento mi vedo affibbiare il compito d’intrattenere Bazlen. Lo avevo visto – credo – solo una volta in vita mia, a Roma. Problema: come intrattenere questo colosso della critica letteraria!?
Gli proposi di recarci a cenare alla Casina Rossa di Torre del Greco.. Pensai che il luogo fosse (come infatti era) talmente poetico, da far dimenticare il fatto che dovevamo appunto, prosaicamente,…”andarci a mangiare”. Bobo aderi’ subito all’idea, ovviamente senza problemi, con curiosità per i luoghi che avremmo visitati e con quella semplice allegria che in seguito, trattandolo, constatai esser nota costante del suo carattere ottimista. E fu una idea felice. Eccoci installati sul bordo del mare, col sottofondo del mormorίo delle onde ora simili a preziose lame di metallo liquido, controsole nel tramonto flegreo.
Bene; ma ora, di che cosa parlare con l’illustre talent scout, scopritore con Joyce e Montale delle meraviglie di Svevo, e iniziatore della voga italiana di Musil? Piuttosto tremebondo, stavo appunto a spremermi le meningi per titar fuori qualche argomento “degno di lui”, ovvero… meno fesso dei miei soliti, quando ecco Bazlen, di punto in bianco e senza por tempo in mezzo, mi confida che non ne puo’ più della sua professione di “lettore di romanzi”. Anzi! non ne puo’ più anche dello stesso genere “romanzo”! In fondo, sempre le stesse storie, camuffate e cucinate in salse solo apparentemente diverse: “la nostalgia dell’infanzia”! Trovava la cosa talmente monotona, da essere persino stupida.
Respirai: Bazlen, bontà sua, certo intuendo il mio disorientamento, metteva in mezzo un argomento semplice, del quale era difficile dichiararsi digiuni. Mi buttai a capofitto sul tema, ed azzardai: “nostalgia dell’infanzia!?”, ma non aveva forse Zeno, nella Coscienza, detto abbastanza intorno alle ingenuità di Freud? E poi, mi scusi Bazlen, non esiste il caso strepitoso di Proust, che non ha affatto nostalgia della sola infanzia? Egli ha nostalgia di tutto e, per farci ben capire questo, scrive ben sette libri!…
Nostalgia! Involontariamente, si era caduti sul tema per eccellenza “mio”. Bazlen mi diede subito ragione con gentilezza, forse con una punta di noncuranza. E, se ben ricordo, dopo avermi avvertito che Edoardo Weiss, l’introduttore di Freud in Italia, era triestino e suo conoscente, mi espose in breve una teoria mirabile relativa al nostro argomento. La sua teoria: quella che qui io, dopo tanti anni, cerco di segnare e di segnalare al lettore.
Questa teoria, dice dunque Bazlen, è già in nuce negli scritti di Marcel Proust, che egli riconosce esser dei pochi che si sottrassero al tema obbligato della “perduta infanzia felice”. Proust, ben diversamente da quanto afferma il banale luogo comune, “ricerca il tempo perduto” non per salvarlo, ma ben al contrario per intenderlo e poi distruggerlo: la sua ricerca è in effetti una mai intermessa ricerca di cio’ che vive nelle terre incognite che si stendono “al di là del tempo”.
Orbene, esaminando l’infanzia, che cosa distingue “il sentimento della vita” del bambino da quello degli adulti? Distingue questi due sentimenti il modo di sentire il tempo. Anzi, il bambino letteralmente “non ha il tempo” nel proprio orizzonte; egli vive in un eterno presente. Ai crudeli avvertimenti che lampeggiano lungo l’esistenza dell’adulto, avvertimenti tutti ovviamente relativi al tempo che passa, il bambino resta insensibile; egli li legge, se pure li nota, come anodini, amichevoli contrappunti che arricchiscono e danno sapore all’ ininterrotto, lieto “motivo” della propria vita.
Le famiglie, fino a qualche anno prima di allora, erano ancora concretamente vive, animate e numerose. Il bambino aveva a disposizione nonni, zii, e clienti vari, che arricchivano il suo ambiente e gli conferivano la poesia che sprigiona dall’assiduo dialogo dell’esistenza in comune. C’era forse una zia che tossiva continuamente, portandosi la mano al petto? Il nonno doveva prendere ad ore fisse pillole essenziali alla sua sopravvivenza? Si’, ma essi avrebbero continuato a far queste cose “per sempre”, instancabili attori della eterna trama che il bambino sentiva sua. Una pièce ed una scenografia senza tempo, e al riparo del dolore.
All’adulto, invece, un parente che tossice spesso, o che prende varie pillole al giorno, inesorabilmente ricorda la silenziosa, incombente minaccia della morte.
Bazlen disse tutto questo con meno parole di quante ne abbia qui adoperate io; e poi ecco aggiunse il necessario equivalente letterario. Questi due tipi di sensibilità, queste due sindromi consentono, disse, di individuare due tipi fondamentali di linguaggio e di aura poetica: la “poesia del sempre” propria al bambino (ed all’adulto che il presente ripercorre, come Gozzano o Carducci); e la “poesia del mai più” propria all’adulto.
E, con un sorrisetto quasi di modestia, ed un “bah! S’è fatto tardi”, Bazlen si alzo’ e si avvio’ alla porta, l’occhio perduto verso l’orizzonte ormai quasi nero.
Respirai. Ero dunque riuscito a fronteggiare la situazione, ed avevo anche imparato qualcosa. Ritornammo a via Crispi percorrendo l’autostrada lentamente, come per attendere il sorgere della luna. Il fatto è che Bazlen mi aveva riempito la testa di idee, come sempre accade quando si colloquia con una persona intelligente. Guidavo meditando, e riandando tra le mie poche informazioni di poesia. Ma subito constatai che il mio interlocutore aveva ragione: ora mi aleggiavano nella memoria da un lato “La nebbia agli irti colli…”, e dall’altro “Volverán las obscuras golondrinas…”.
Ripenso, con nostalgia (dunque, adottando anch’io la poesia di “secondo tipo”!), alla figura cosi’ umana di Bobo Bazlen, alla Santa Maria la Bruna ora distrutta e sostituita da selve di grattacieli, alla Napoli d’un tempo, dove potevano viversi serate cosi’ tranquille, presso il mare, ascoltando nel silenzio assorto la “lezione universitaria” d’un uomo di valore.
Naturalmente altri vivono e vivranno ore di consimile pregio, certo. La vita non si lascia arrestare da un manipolo di geometri imbecilli e di speculatori mascalzoni. Ma per me, dico per quanto mi concerne, la faccenda è conclusa. Sono servito, come si dice. La poesia è sempre particolarissima, voglio dire è ogni volta unica. E cosi’ di quella peculiare poesia, di quei luoghi, di quel tempo ancora benedetto perché indenne dalla mano dei deturpatori, di quelle pregevoli persone ancora non contaminate dal mercantile ghigno dello spettacolo televisivo e, last not least, di me, del sottoscritto di allora, non resta più nulla.
Leonardo Cammarano, 27 giugno 2011
Ripreso da Zona di frontiera (Facebook) – zonadifrontiera.org (Sito Web)
27 giugno 2011

